Il problema delle IA nella scienza: reale o fittizio?
-
Cristian Rossi
- 19 Apr, 2025
- 08 Mins read
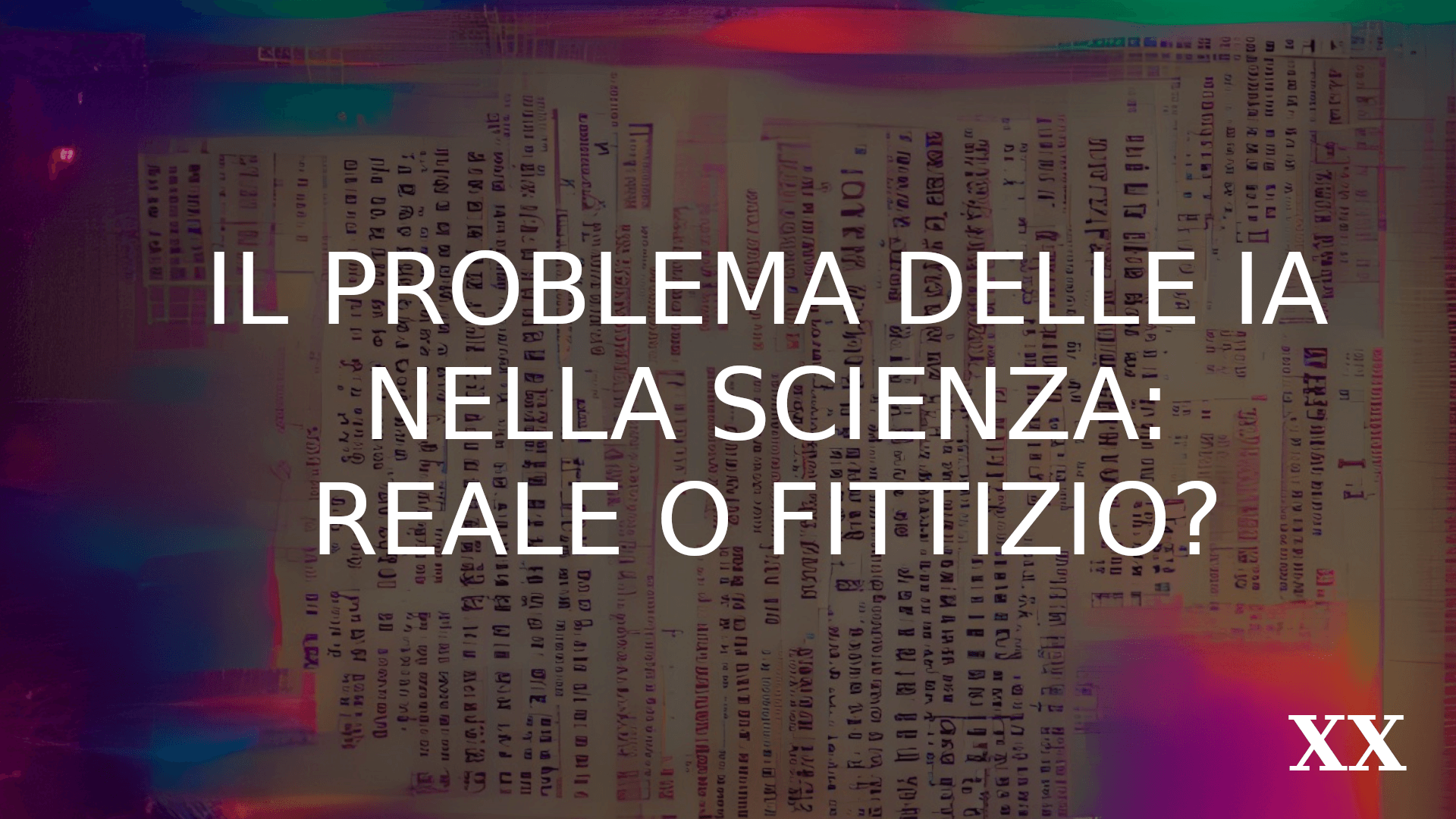
Il problema discusso nel precedente post ci porta a considerare come la percezione della realtà possa essere deviata molto più facilmente del previsto e di come l'illusione, nonostante possa essere contrastata dalla misura, rimane sempre vigente, soprattutto al giorno d'oggi che grazie all'intelligenza artificiale porta alla produzione di contenuti che non sono reali. Le truffe telefoniche aumentano, così come aumenteranno nei prossimi anni quelle di altro tipo sottoforma di attacchi di spoofing (dove uno si finge un'altra persona) o più in generale di ingegneria sociale. In un contesto scientifico il problema è ancora più grave, poiché i dati in un dataset potrebbero essere generati ad hoc per una determinata teoria, facendola risultare come vera, lasciando solo al tempo e a gente che sperimenta davvero, la pubblicazione di dati reali e coerenti con la realtà. Il conflitto di interesse nel campo della data science genera conflitti, ed in contesto tecnico, ciò che si chiama overfitting. Tale fenomeno potrebbe essere descritto come il "rumore dei dati", ovvero ciò che porta ad una maggiore complessità rispetto alla qualità e o alla qualità dei dati disponibili, tanto da aderire eccessivamente ai punti dati osservati, inclusi eventuali errori o fluttuazioni casuali (rumore). Di conseguenza il risultato di questo overfitting è che il modello ottenuto rappresenta sì fedelmente il campione, ma non risulta affidabile nel descrivere la popolazione da cui il campione è tratto. Le conseguenze riguardano pertanto la stima distorta dei parametri, la scarsa capacità predittiva fuori campione, l'errore di varianza elevato, la falsa scoperta di relazioni, la compromissione dell'affidabilità delle inferenze, la ridotta parsimonia (violazione del principio di Occam) e soprattutto la compromissione della verità come conseguenza di uno studio statistico. Lato statistico ci sono delle mitigazioni che permettono o di ridurre l'overfitting o di capire se i dati sono stati generati, come la riduzione della complessità del modello, la regularizzazione, la cross-validation, la selezione delle variabili, l'aumento della dimensione del campione e così via, ma essendo delle mitigazioni e non delle risoluzioni, può essere che ci possano essere dei modelli statistici o dei dati che possano superare questi "filtri", portando a risultati falsamente veri.
Una possibilità quasi distopica potrebbe riguardare la registrazione di ciascun dato di un esperimento con una firma quantistica, ottenuta dalla registrazione del "rumore" della fluttuazione quantistica di una determinata area, come può essere l'attenuazione di una fibra ottica, la turbolenza nel vuoto, la decoerenza temporale, l'interferenza elettromagnetica, etc. Dunque la proposta sarebbe che quando accade un evento fisico reale, avviene un'interazione con uno strumento fisico, il che significa che il segnale analogico viene convertito in un segnale digitale, tale da fornire dei dati grezzi sottoforma di bit. Questi dati grezzi verrebbero contrassegnati dalla fluttuazione quantistica registrata in un determinato momento (difficilmente coincidente con il momento della misura effettiva) che fungerebbe da firma quantistica. L'encoding di ciascun dato potrebbe essere ottenuto tra l'altro in maniera simile al funzionamento della chiave asimmetrica, così che si possa riconoscerne effettivamente l'autenticità. Ma ogni strumento dovrebbe essere tarato e registrato in un registro pubblico di difficile contraffazione, stando al passo coi tempi in qualcosa come una blockchain. Ma qui ci sarebbe il problema che potrebbe ancora una volta essere tutto simulato, sia la firma quantistica che lo strumento di misura stesso. Tanenbaum questo nel suo libro "l'architettura dei calcolatori" lo definisce in maniera ben definita, descrivendo come il software possa essere convertito in hardware ma di come anche l'hardware possa essere convertito tutto in software (necessitando comunque di un hardware che lo possa eseguire). In un contesto ontologico potremmo definire come tutto ciò di cui possiamo discutere, essendo l'esposizione per mezzo di un linguaggio specifico degli aggregati di proprietà, che sono essi stessi proprietà, possono essere in qualche modo realizzati nella realtà, essendo che hanno delle relazioni specifiche e fattibili. Ciò che non permette di realizzare determinate cose è relativo unicamente al comportamento delle interazioni fondamentali della realtà: gravitazionale, elettromagnetica, nucleare forte e nucleare debole, governate in realtà anche loro dalla logica, che è alla base persino della matematica e del concetto stesso di quantità. La logica è a sua volta governata dall'ontologia e quindi dall'esplicito ed implicito e dalla negazione, a sua volta fondata sull'essere. Il fondamento di ogni cosa è l'essere e come tale, per le sue differenziazioni a seguire troviamo la chiave della distinzione che sussiste tra la realtà e la finzione. Ma se tutto può essere simulato, cosa è reale e cosa no? Il semplice discorso sull'essere non basta da solo per potere definire argomenti di così alto livello come la cognizione del reale (lo potremmo fare, ma uscirebbe una spiegazione troppo lunga e prolissa per lo scopo di questo post), per questo dovremo includere un nuovo elemento, in realtà già argomentato dal filosofo Max Stirner, il fondatore dell'anarchia (se coerente può essere unicamente individualista): l'egoismo, ovvero l'abbattimento di ogni visione impersonale, sia essa un'ideologia o un sistema filosofico, che si pone al di sopra dell'individuo che dispone di una determinata cognizione ontologica cosciente.
Secondo Max Stirner questi "-ismi", come il liberalismo, il comunismo, l'umanesimo, etc., non sono altro che nuove forme di culto secolare, cioè fantasmi mentali (che lui definiva con il nome tedesco "spuk"), che si impongono sulla propria cognizione del reale, alienandolo. Per alienare è necessaria una contraddizione ontologica e la metafisica presenta proprio questo problema, ovvero la considerazione che l'ente essendo una manifestazione dello spirito (la realtà metafisica per eccellenza) sia meno reale. Ciascuna ontologia presenta un'istanza ontologica più reale delle altre, come per esempio nell'empirismo ciò che è più reale è l'ente. Nell'ontologia dialettica fondata sull'essere che viene proposta in TheoryFlow, essendo che tutto è proprietà, fuorché l'essere, che è l'istanza che permette le proprietà, tutto esistendo è reale. La distinzione tra reale e fittizio nell'ontologia dell'essere decade, lasciando spazio unicamente ad una narrativa ontologica di ciò che è. Persino il possibile e l'impossibile per l'essere non trova delle distinzioni, ma anche l'indicibile essendo essere esiste. Potremmo definire che gli unici criteri per potere capire se qualcosa può essere definito come un falso a priori sono i semata ontologici accennati in questoarticolo. I semata ontologici (i contrassegni dell'essere) sono 7 e sono unicità, eternità, ingenerabilità, immutabilità, indivisibilità, immobilità e pienezza. Potremmo definire che una teoria potrebbe violare i semata se:
- per l'unicità scinda l'essere.
- per l'eternità l'essere smetta di essere eterno.
- per l'ingenerabilità venga asserito che l'essere possa essere generato.
- per l'immutabilità l'essere possa mutare.
- per l'indivisibilità l'essere abbia divisioni in sé stesso.
- per l'immobilità l'essere possa muoversi.
- per la pienezza l'essere ammette il non essere entro sé stesso. Una volta verificata almeno una di queste condizioni allora la proposizione è contraria all'ontologia, ed è falsa a priori. La verità a priori non potendo essere argomentata, sfugge all'ontologia e necessita proprio dell'egoismo stirneriano accennato poco fa.
Il linguaggio, poiché espone una narrativa teorica, cioè un flusso di dati vincolato al mito ("le origini del pensiero scientifico", Santillana), ciò che riguarda sé stessi e non gli altri è ciò che è tangibile e viene concepito come sensibile, cioè con una proprietà determinata come obiettivo narrativo egoistico. Ciò che è scientifico è ciò che è egoisticamente correlato ai propri interessi, ovvero a ciò che interessa il proprio organismo in quanto potenzialmente tangibile. È epistemico ciò di cui possiamo fare esperienza tramite un esperimento, ed è sperimentabile ciò di cui possiamo ottenere una misura entro una chiave narrativa che correla un evento fisico ad una determinata narrativa, determinata a sua volta da un'ontologia di sfondo. Il modello dell'atomo di Rutherford è rimasto per molti ancora oggi lo standard narrativo del comportamento dell'atomo e delle sue componenti, ma la teoria fisica odierna ce lo argomenta unicamente come l'epifenomeno di unità minori, fino a giungere al campo quantistico, che matematicamente è molto più coerente di altri modelli matematici che descrivono la realtà. Evolvere la scienza significa pertanto affinarla verso una narrazione più coerente con lo sviluppo, più o meno esplicito, di un'ontologia di sfondo, e poiché l'ontologia è riferita sempre alla cognizione individuale, nonché a come l'essere viene descritto e le sue differenziazioni organizzate a livello psicologico, alla base dello sviluppo della scienza stessa rimane sempre l'individuo. L'esperienza di un qualcosa, sia essa diretta o tramite la lettura di una misura su uno strumento, è altresì condizionata dall'ontologia e dalla capacità di potere indagare le proprietà di un sistema, sia esso l'ambiente sperimentale o lo strumento di misura. Per fare scienza e dunque per distinguere la realtà dalla finzione, non è più possibile agire da semplici automi, ma si rende necessaria l'attività circa la conoscenza di ciò che si va a prendere in causa per esperire, per interagire nel mondo in un determinato modo. Avere coscienza di sé e di ciò che si fa è il fondamento del proprio interesse, ed è il fondamento della conoscenza scientifica. Senza individuo non ci può essere scienza, poiché rimane unicamente una narrativa vuota e fine a sé stessa. In altre parole, è extra narrativo ciò che riguarda sé stessi e la propria vita. Il ricordo di un evento passa ad essere narrativo nella misura in cui rimane dialetticamente sconnesso dall'esperienza sensibile che se ne fa. E se per assurdo uno non avesse a disposizione i sensi per potere indagare la realtà, rimarrebbe vincolato unicamente ad una forma narrativa fine a sé stessa. E non è forse questo che fanno le intelligenze artificiali? Aggregano senza uno scopo e, attualmente, non hanno possibilità di esperire il reale, essendo che sono prive di sensi, cioè non ricevono un feedback rispetto a ciò che accade rispetto a ciò che viene da loro generato (atteso). Esse potranno generare immagini epistemicamente impossibili ma non avranno mai la possibilità di potere misurare nella realtà fisica quanto generato, poiché rimarrà solo un'esistenza inerente alla narrativa di quell'IA. Ciascun elemento ha, più o meno coscientemente (il riferimento è qui di Tononi e al suo indice di coscienza phi) la sua narrativa, ma ciò che fa la differenza sta proprio nella possibilità di potere integrare la narrativa nella fisicità del mondo, in ciò che riguarda le 4 interazioni fondamentali. Un quadrato rotondo è reale? No, perché non possiamo farne esperienza (tramite un esperimento) ed è in contraddizione con le teorie derivate dalle 4 interazioni fondamentali. Un tavolo è reale solo perché è narrativamente esposto tramite una determinata interazione sensibile, un ologramma è reale come ologramma e non come tavolo in legno perché non offre quell'interazione che ci si aspetterebbe col legno. Di conseguenza, come detto prima, la differenza tra reale e non reale non esiste, esiste tutto sullo stesso piano, che è quello della narrazione dell'essere, essendo che l'essere ne è il soggetto. Possiamo al massimo definire fisico ciò che interagisce con noi stessi e che possiamo fingere che sia fisico asserendo per assurdo all'esistenza di qualcosa di fittizio come una palla rossa che in realtà non abbiamo, oppure come conseguenza di considerazioni che hanno delle proprietà fisiche. Quindi per esempio sappiamo dell'esistenza di un qualcosa di remoto come una galassia perché è conseguenza di determinati studi, come per esempio la rilevazione infrarossa del cosmo. In sintesi, non c'è differenza fra reale e fittizio sul piano ontologico, la differenza è solo tra le proprietà che riguardano l'interazione di sé stessi con gli altri aggregati. Più un aggregato è "distante" (cioè che non ne è egoisticamente coinvolto) da un altro e più è fittizio. Per esempio, un personaggio di fantasia come Bugs Bunny rispetto a sé stessi sarà "vicino" solo al massimo tramite la visione dei suoi cartoni animati (con la relativa integrazione psicologica) e non tramite altro come per esempio il lavoro del legno, essendo comunque che ontologicamente parlando, il legno ha più proprietà epistemiche (che interagiscono con sé stessi per mezzo delle 4 interazioni fondamentali) rispetto a Bugs Bunny.
Perché non possiamo fare affidamento alle semplici 4 interazioni fondamentali? Ciò che è fisico è vero che si fonda su di esse, ma risultati di alto livello sono difficilmente riscontrabili tramite un analisi di così basso livello. Per esempio, se si volesse testare un determinato effetto atteso da un farmaco si dovrà necessariamente sperimentarlo su qualche esemplare in maniera reale, cioè fisica, ma difficilmente si potrà avere una qualche riscontro solo dall'analisi dei dati, perché i dati rimangono unicamente una narrativa dell'esperimento, mentre l'esperimento stesso è ciò che interessa l'individuo in quanto partecipante della realtà. Ed è qui il limite della comunità scientifica: i singoli membri non potranno intelligere direttamente l'evento ma potranno solo elaborarlo in base alla narrativa già elaborata da chi ha fatto l'esperimento. E anche se si trasmettesse in streaming video, rimarrebbe sempre comunque un canale compromettibile, l'unica maniera per fare un esperimento è farlo e ciò che riguarda il valore di verità rispetto ad un evento di cui non si può ottenere un esperimento diretto, è insperimentabile, pertanto non egoisticamente coinvolgente, narrativa di un fatto di cui non è possibile risalire alla sua veridicità fisica, poiché la scienza ammette sempre partecipazione. La scienza attuale è il risultato sì della speculazione narrativa di ulteriori narrazioni, ma queste non sono esenti dalle indagini, poiché sulla scienza prevale sempre e comunque il mito, che altro non è che la narrazione ontologica per eccellenza che tenta di argomentare la realtà. I dati falsi fanno parte della narrazione ontologica e quella delle IA è necessaria poiché espone come una presa di decisione sia resa da dei bias posti in base ad una qualche posizione, sempre derivata dall'ontologia assunta e nel caso della scienza attuale si tratta quasi sempre dell'ideologia del socialismo, definibile anche come anti-egoismo.